Parto, in questo editoriale, da una passione personale, quella per la cultura dei nativi americani, riprendendo una frase molto ricorrente nelle preghiere Lakota (da noi conosciuti come Sioux): Mitakuye Oyasin. Significa “Siamo tutti connessi”, facciamo tutti parte di un’unica comunità, quella degli esseri umani appartenenti a un tutt’uno con la dimensione naturale della terra e del vento, del sole e dell’acqua.
Perdonatemi l’inizio un po’ “spiritualista” ma i Lakota (e le centinaia di tribù di nativi americani) a partire dalla scoperta dell’America da parte di Colombo e fino alla fine dell’800, quando l’uomo bianco li ha sistematicamente sterminati in nome del progresso e della proprietà (forse non tutti sanno che una volta vinti e sradicati dalle loro terre, le compagnie governative americane distribuivano ai nativi delle riserve le coperte con il virus del vaiolo, per farli morire prima), hanno sempre vissuto con questa intima convinzione di appartenenza comune, di necessità di condivisione di risorse, di scambio.
Anche le feroci guerre intertribali avevano quasi sempre l’obiettivo di garantire equilibrio ambientale, sopravvivenza della tribù, acquisizione o mantenimento di territorio per poter continuare a vivere secondo un modello di forte interdipendenza. Mai è stata perseguita la logica dell’espansionismo fine a se stesso oppure finalizzato al benessere personale e all’accumulazione.
Una lezione che noi certamente non abbiamo appreso. Ma dell’affascinante quanto terribile storia dei nativi americani, prendiamo oggi soltanto il senso della relazione: antesignani di Facebook? Forse i segnali di fumo erano le prime forme di e-mail e di Unified communication?
Il tema della relazione e condivisione è molto antico. Oggi lo stiamo vivendo (e talvolta subendo attraverso un profondo cambiamento dei nostri modelli di vita), grazie all’evoluzione tecnologica che offre grandi potenzialità di “relazioni digitali” in cui la velocità e la quantità, sempre maggiore, di funzioni e di integrazioni tra esse consente nuove modalità per confrontarsi, condividere e collaborare.
È una potenzialità di digital collaboration che per essere sfruttata e non esserne piuttosto schiavi, deve calarsi in una consapevolezza di approccio, di mentalità, quasi di filosofia della comunicazione e collaborazione, che, ad esempio, i nativi americani avevano addirittura formalizzato nelle loro preghiere a Wakan Tanka, il Grande Spirito (il macro e il microcosmo, la luce e la tenebra, il maschile e il femminile, a rafforzare il concetto che le dualità e le diversità sono alla base della vita, indipendentemente dalla forma con la quale queste si manifestino, e quindi si possono aggregare tra loro in forme collaborative – guardate quanto ancora è attuale questo messaggio).

Andiamo al punto: se non sapremo sviluppare modelli collaborativi, le tecnologie ci porteranno su strade che non governeremo. Potremo approfittare delle opportunità tecnologiche, ma non sapremo vedere il cammino e “scaricare a terra” in termini di idee, progetti, capacità attuative, una serie di contatti e confronti che potrebbero rivelarsi alla lunga fine a se stessi, inutili e sfiancanti (è in corso una pesante revisione del valore del modello di relazione via Facebook). E questo è un problema da affrontare sia sul piano dello sviluppo organizzativo di impresa sia individuale, come consumatori “sempre connessi” al Web.
Facciamo un esempio concreto: prendiamo spunto da un articolo di questa Storia di Copertina, dedicata alla Software Economy, nella quale vengono analizzati anche i modelli di sviluppo di App e di servizi, che si stanno ripensando in profondità secondo criteri fortemente collaborativi, unica risposta possibile alla attuale complessità e velocità dei mercati. Il Copenhagen Institute of Interaction Design, uno dei principali centri europei di ricerca, formazione e consulenza mondiale, ha impostato da tempo il proprio modello operativo e il proprio successo (vanta tra i propri clienti grandi multinazionali come Intel, Nokia, Philips, Toyota, Volkswagen, ecc.) non tanto su team interdisciplinari (in cui persone esperte lavorano separatamente e si incontrano con periodicità per confronti e nuove fasi di sviluppo) quanto su team cross-disciplinari, nei quali persone con diverse competenze lavorano insieme sul progetto con l’obiettivo di creare prototipi nei quali si fondono diversi linguaggi e dai quali scaturiscono nuove opportunità anche non previste. Un esempio: per Toyota l’Istituto aveva avuto il compito di interpretare per il mercato europeo l’obiettivo di incrementare le vendite della Yaris, agendo sui valori distintivi della società giapponese. Partendo dal fatto che la Yaris, secondo un recente studio realizzato dalla Casa automobilistica, era stata acquistata soprattutto per la qualità dei servizi digitali offerti, il team collaborativo dell’Istituto ha messo a punto un lavoro nel quale le direttrici di riferimento erano: facilitare le interazioni con le persone ed essere in simbiosi con la natura. Risultato? “Windows of the world”, una nuova relazione tra i passeggeri dell’auto e l’ambiente esterno con cui ci si rapporta attraverso il finestrino, che diventa un’interfaccia interattiva con cui zoomare il paesaggio, fruire di informazioni, fare fotografie, ecc. Cosa c’è stato alla base di questa idea? Un modello collaborativo forte, sul quale sono intervenute a valle le tecnologie a supporto.
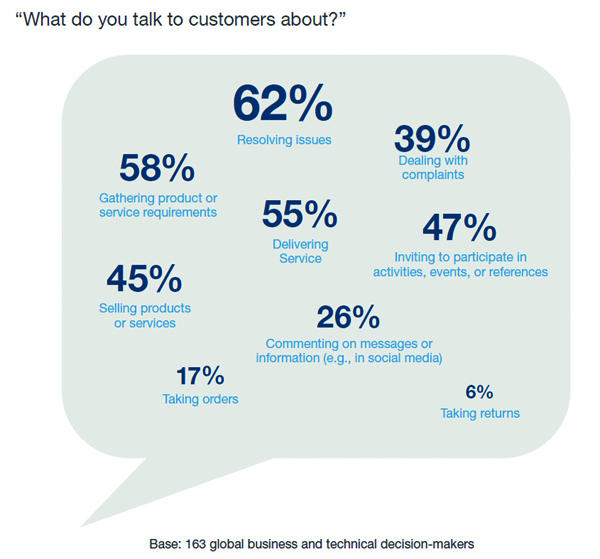
La collaborazione può svilupparsi internamente all’impresa e al suo ecosistema e anche tra impresa e mercato. In entrambe le situazioni l’It può giocare la sua partita. Nel primo caso deve essere in grado di esplicitare un ruolo di abilitatore che parta dalla conoscenza reale delle strategie aziendali per poi declinare, attraverso corrette scelte tecnologiche (con il cloud ormai al centro di molte proposte), i criteri e le modalità di relazione con cui lavorano le persone. Un assessment non semplice ma fondamentale per dare, abilitare, talvolta anche limitare le tecnologie digitali, con l’obiettivo ultimo di utilità non soltanto nella comunicazione ma, come si diceva prima, nel portare risultato, semplificazione di vita (lavorativa) e reale capacità innovativa.
Nel rapporto impresa-cliente, invece, il tema è quello, centrale, di una collaborazione e condivisione realmente basata sulla fiducia. E costruire la fiducia non è cosa semplice né rapida. Capire i bisogni reali attraverso una vera collaborazione e condivisione abilitate dalla tecnologia è il presupposto per arrivare a una fidelizzazione e a una percezione del brand che si traduca davvero, da un lato, in opportunità di business, e dall’altro che porti l’azienda ad essere realmente espressione (attraverso i propri prodotti e i servizi) di un’esigenza o di un indirizzo espresso dalla comunità, da cluster di persone, fino addirittura a soddisfare le specifiche esigenze del singolo consumatore. Occhio quindi allo sfruttamento selvaggio di nominativi. Un recente Report Symantec (State of Privacy 2015) raccoglie i risultati di un’indagine condotta dalla società americana su circa 7.000 cittadini dell’Unione Europea per sondare l’opinione pubblica in merito alla sicurezza delle informazioni sul Web: il 57% degli europei pensa oggi che i propri dati non siano al sicuro, mentre il 59% ha riscontrato in passato problemi riguardanti la protezione dei dati e la privacy. Vedremo se la percezione cambierà soprattutto con il passare degli anni, quando cioè le nuove generazioni, tipicamente incuranti di questi aspetti, aumenteranno la loro capacità di spesa. Di fatto, i modelli collaborativi (e le relative tecnologie) sono alla base di un cambiamento profondo nel modo di fare oggi impresa in una società iperconnessa. Basta avere la consapevolezza del valore di questa interdipendenza e su questa costruire modelli relazionali più vicini a noi, alla natura del nostro essere individui e al contempo comunità, prima ancora che soltanto consumatori. Mitakuye Oyasin
















