Molti analisti riconoscono che la scarsa competitività dell’Italia, evidenziata anche dal quadro emerso nell’articolo precedente, non è conseguenza della crisi ma è purtroppo un dato strutturale, causato dalla necessità di ricollocazione del Paese nella divisione internazionale del lavoro. Un parametro indicativo è la quota modesta di esportazioni dell’Italia ad alto contenuto tecnologico sul totale dell’export (10,8%), la quota più bassa fra i paesi avanzati esaminati nella figura 1, metà di quella della Francia e della Germania e un terzo di quella del Regno Unito.
A conferma della specializzazione italiana nei settori ancora più tradizionali dell’economia, la quota complessiva di esportazioni a medio-basso o basso contenuto tecnologico era del 49,3% nel 2009. Del tutto conseguentemente l’Italia figura nel gruppo dei modesti innovatori. Anche se il Paese è caratterizzato da punte di eccellenza, si deve ammettere che il sistema nel suo complesso risulta poco innovativo.
Lo sviluppo tecnologico può invece mettere in campo produzioni high-tech in grado di generare valore aggiunto per addetto superiore rispetto a quello dei comparti a medio-bassa tecnologia, con importanti conseguenze per la crescita economica. L’innovazione, soprattutto se basata sulla digitalizzazione, ha inoltre non solo la capacità di far nascere nuove imprese, ma quella di “rigenerare industria esistente”, che rappresenta uno degli obiettivi di Hit 2020 (la declinazione italiana di Horizon2020, documento europeo di programmazione settennale su ricerca e innovazione). Ma, va precisato, gli investimenti in R&D e la qualità della ricerca non si traducono automaticamente in innovazione.
Superare il gap fra ricerca a innovazione
 Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa e membro del Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur)
Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa e membro del Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur)Come ci ricorda Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa e membro del Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur): “Nel settore Ict la distanza fra innovazione e ricerca è molto elevata. Una componente significativa è rappresentata dall’uso improduttivo, ai fini dell’innovazione, della domanda pubblica che rappresenta mediamente a livello europeo il 15%”. Non si tratta di un problema solo italiano, ma è una conseguenza del codice europeo degli appalti. Utile per garantire la trasparenza nei settori maturi, rende però impossibile l’acquisto da parte della PA di soluzioni innovative “con il rischio di allargare lo iato fra ricerca e mercato”, come commenta Bonaccorsi, ricordando “le centinaia di progetti finanziati che hanno consentito di realizzare soluzioni brillantissime che nessuno applica”. Le startup, portatrici spesso di prodotti e servizi particolarmente innovativi, non riescono a vendere alla PA non solo a causa dei lunghi tempi di pagamento che mal si concilia con la loro debolezza finanziaria, ma soprattutto perché acquisire soluzioni innovative viene considerato troppo rischioso. In questo ambito l’Italia sta individuando alcune soluzioni su cui torneremo di seguito.
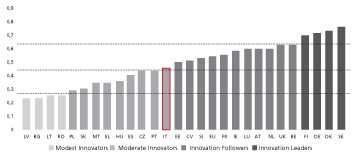 Figura 1: Esportazioni del settore manifatturiero per intensità tecnologica nei principali paesi industrializzati, 2009 Fonte: Horizon 2020 Italia, da dati Oecd, Stan Bilateral Trade Indicators Database, 2012
Figura 1: Esportazioni del settore manifatturiero per intensità tecnologica nei principali paesi industrializzati, 2009 Fonte: Horizon 2020 Italia, da dati Oecd, Stan Bilateral Trade Indicators Database, 2012
Nel miglioramento del rapporto fra ricerca e innovazione il rapporto Anvur (vedi correlata dal titolo "Quale Ricerca & Innovazione in Italia?") può rappresentare un punto di partenza che, evidenziando un aumento di consapevolezza sia sul versante della domanda sia su quello dell’offerta di ricerca, consente a tutti gli enti di misurarsi con gli altri e nel quadro internazionale. “Il risultato più importante è, in ogni caso, che ciascuno si valuti e che l’industria abbia la disponibilità della mappa delle competenze – sottolinea Bonaccorsi – Uno sforzo che darà molti frutti in quanto non si tratta di un’iniziativa episodica, ma di un impegno permanente”.
Una lettura attenta del Rapporto evidenzia che il vero problema non è tanto la carenza di ricerca di qualità quanto la capacità di metterla in luce e soprattutto di sfruttarla per fare innovazione.
 Alfonso Fuggetta, amministratore delegato di Cefriel
Alfonso Fuggetta, amministratore delegato di Cefriel
“Ci sono indubbiamente alcuni poli di eccellenza”, dice Alfonso Fuggetta, amministratore delegato di Cefriel, azienda del Politecnico di Milano creata per supportare i processi di innovazione delle imprese in ambito Ict e ridurre il distacco fra università e imprese attraverso un approccio multidisciplinare. Fuggetta cita a memoria poli come Torino, Milano, l’asse emiliano, Padova, Pisa, Roma La Sapienza, Trento, che potrebbero rappresentare elementi di attrazione per i cervelli. “I giovani ricercatori ci sono e sono bravi e per questo scappano all’estero”, si rammarica.
In particolare ci sono alcune tematiche in ambito It su cui tanti ricercatori stanno lavorando e che potrebbero avere ricadute immediate come lo sviluppo di software sicuro in mobilità (come monitorarlo, come svilupparlo?), le analytics e le annesse problematiche di visualizzazione (non solo datawarehousing ma come si rappresentano e si comunicano). C’è poi il tema della semplificazione dei sistemi e la necessità di ripensare le applicazioni in una nuova ottica. “Siamo di fronte a un’ondata di nuovi sistemi e nuovi interfacce – ricorda Fuggetta – Pensavamo che la guerra dei sistemi operativi fosse finita anni fa, ma oggi è invece in pieno svolgimento”.
Il mercato, sul versante della domanda di innovazione e ricerca, secondo Fuggetta è pronto. Ma il punto critico sembra essere l’offerta che dovrebbe fornire le soluzioni: “Probabilmente le imprese andrebbero aiutate con politiche pubbliche appropriate, venture capital e con acquisti pubblici intelligenti”, suggerisce Fuggetta.
La domanda pubblica come stimolo della ricerca
L’ultimo suggerimento ci riporta al ruolo che le amministrazioni pubbliche potrebbero svolgere per tradurre la ricerca in innovazione “L’Italia, che fino allo scorso anno era, nell’ambito della domanda pubblica, il fanalino di coda, oggi si è guadagnata le stellette sul campo”, comunica Bonaccorsi. Negli ultimi mesi, alcune regioni in accordo con i Ministeri dello Sviluppo Economico (Mise) e dell’Istruzione Università e Ricerca (Miur) hanno definito bandi per appalti pre-commerciali volti al finanziamento dell’innovazione per acquisire R&D sulla base di specifiche definite dalle amministrazioni. In pratica si aprono competizioni fra più fornitori per definire le migliori soluzioni per gli utilizzatori: non solo idee o soluzioni pronte, ma servizi utilizzabili basati su proposte innovative. Il processo prevede che le amministrazioni riuniscano gli utilizzatori potenziali delle soluzioni e che questi indichino in modo preciso i fabbisogni futuri. Vengono coinvolti i soggetti che offrono diverse soluzioni (prototipi funzionanti) in concorrenza fra loro; l’attività di ricerca viene finanziata congiuntamente da Miur e Mise, che rendono disponibili 150 milioni di finanziamento per amministrazione. Alcune regioni, fra cui la Puglia, la Lombardia, la Valle d’Aosta, l’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano, hanno già aderito. A conclusione dell’attività di ricerca verranno scelti i progetti considerati più idonei e, a cascata, seguiranno i bandi delle amministrazioni rivolti alle imprese per tradurre i progetti in soluzioni operative.
Il modello sopra descritto usa la domanda della PA come leva per l’innovazione, ma non risolve il problema di incentivare l’R&D delle imprese e per le imprese. Fuggetta porta ad esempio il modello Usa, il cosiddetto “dollar match”: per ogni investimento privato lo stato contribuisce per una somma equivalente (1 dollaro pubblico per ogni dollaro privato).
“Purtroppo, però, le nostre aziende non hanno le dimensioni per investire in ricerca anche se sostenute – ammette Fuggetta – Il mito del piccolo è bello non aiuta l’innovazione e la competitività. Il valore non è essere piccoli, ma agili”.
È una lezione che chi sta sui mercati internazionali, fa innovazione e va bene, ha già appreso. “Solo gli imprenditori che rischiano e fanno cose nuove colgono le opportunità di successo – sottolinea Fuggetta – L’alternativa è limitarsi al mercato captive, sempre più difficile da mantenere, impossibile da ampliare”.
Sul versante dell’offerta, per la ricerca pubblica la prima tipologia di imprese richiede soprattutto capacità di adattamento a tempi e organizzazioni diversi, visto che nella maggioranza dei casi si tratta di interfacciarsi con aziende che operano in settori tradizionali.
 Figura 2: Indice di innovazione dei paesi europei da Graduatoria dello Innovation Union Scoreboard 2011 Fonte: Horizon 2020 Italia, da dati Oecd, Stan Bilateral Trade Indicators Database, 2012
Figura 2: Indice di innovazione dei paesi europei da Graduatoria dello Innovation Union Scoreboard 2011 Fonte: Horizon 2020 Italia, da dati Oecd, Stan Bilateral Trade Indicators Database, 2012
Le aziende dell’Ict non fanno ricerca in Italia: le poche nazionali, tranne rare eccezioni, sono troppo piccole, mentre “le multinazionali dell’Ict hanno rinunciato da tempo, considerando il Paese esclusivamente come un mercato: ne risulta un impoverimento netto”, commenta Bonaccorsi, che aggiunge “Alcuni casi sporadici come quello di Trento che vede il coinvolgimento di una multinazionale come Microsoft, si sostiene soprattutto “grazie soprattutto agli investimenti della Provincia autonoma”. Anche quando queste aziende commissionano ricerche, utilizzano il knowhow italiano per sviluppare altrove i prodotti, non hanno più propri centri strutturati nel nostro Paese, come accadeva fino a qualche anno fa.
“Per le grandi imprese che operano in altri settori, il rapporto con la ricerca pubblica è strutturale; si tratta semmai di adattare le due organizzazioni, di definire adeguate modalità contrattuali e funzionali”, concorda Bonaccorsi ricordando che il problema è la debolezza della grande impresa italiana.
Sul versante delle piccole imprese “il tema vero è come aiutarle a fare ricerca, ma soprattutto come farle crescere affinché abbiano dimensioni tali da poter sfruttare l’innovazione che proviene dalla ricerca”, sottolinea Fuggetta. Il primo obiettivo per le imprese di tutte le dimensioni, e soprattutto per le piccole che non hanno una struttura interna dedicata, a suo parere è di poter utilizzare modalità facili e automatiche, come il credito di imposta e studiare opportuni incentivi per merger&acquisition con l’obiettivo di favorire la crescita.
Secondo Bonaccorsi, la domanda di ricerca da parte delle Pmi è debole e l’offerta difficilmente può partire direttamente dall’Università. “Sarebbe necessario sviluppare nuovi profili professionali riconosciuti, capaci di svolgere un ruolo di intermediazione e valorizzazione della ricerca identificando i modelli migliori”, suggerisce Bonaccorsi.
“Per incentivare l’innovazione e favorire l’occupazione dei giovani c’è un disperato bisogno di semplificazione, di agilità, di flessibilità e di snellimento delle regole mercato del lavoro”, conclude Fuggetta, suggerendo di emulare i programmi nazionali che funzionano di altri paesi europei per l’insediamento delle imprese, il cofinanziamento della ricerca, la riduzione delle tasse…


















